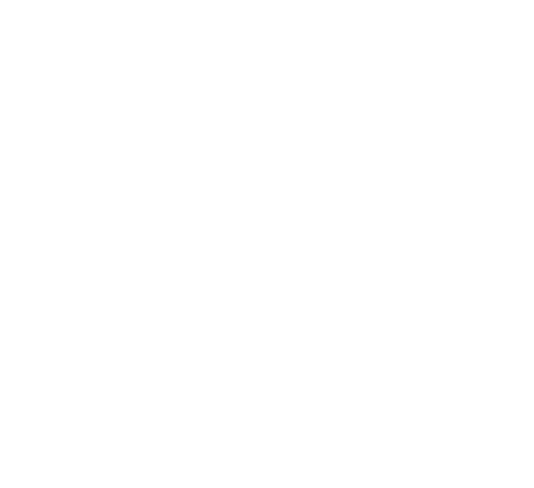L’introduzione della Mediazione Penale Minorile in Italia, quale strumento di “Giustizia Riparativa” – perché questo è il modello adottato nel nostro Paese (rispetto ai sistemi di Giustizia “Retributiva” o “Riabilitativa”) ha costituito un’importante novità, orientata sia alla rieducazione dell’autore del reato, sia alla identificazione di una collocazione para-processuale della vittima del reato, la quale, come noto, non ha facoltà di costituirsi parte civile nel processo minorile (art. 10 DPR 448/88).
Si tratta di un percorso stragiudiziale che può essere introdotto dai soggetti legittimati (Magistrati – PM, GIP, Dibattimento – Assistenti Sociali, Autore del reato o Vittima), in una delle fasi del processo, quali le indagini preliminari, udienza preliminare o dibattimento, a secondo del caso, della valutazione della personalità dell’autore del reato, dell’esito dell’interrogatorio al quale viene sottoposto sempre l’autore del reato.
La Mediazione Penale Minorile è nata sulla scorta di esempio già in vigore presso altre Nazioni, circostanza che ha consentito di individuare, non tanto a livello legislativo, quanto empirico, la caratteristica del Mediatore e della procedura di mediazione stessa.
In particolare, il Mediatore deve avere delle conoscenze di diritto penale, diritto processuale penale, ma anche, e forse soprattutto, di criminologia, di devianze criminale, di vittimizzazione (primaria e secondaria) e scienze di natura empirica (cfr. “The Criminal and His Victime”).
Il panorama italiano in tema di Mediazione Penale Minorile presenta caratteristiche tipiche delle fasi iniziali di sperimentazione, da un lato, forse per carenza di cultura giuridico–sociale, dall’altro, per un’impostazione ideologica diffusa, che vede nella punizione e, conseguentemente, nel sistema retributivo, un’efficace e garantista strumento di difesa sociale; insomma, un contesto sociale che fa fatica ad assorbire il concetto di riorganizzazione relazionale autore–vittima.
La tesi prevalente in Italia è quella di tipo riparativo in presenza di aspetti giuridico-sociali e culturali che vedono nella riparazione del danno reale o simbolico che sia una prerogativa irrinunciabile.
Al di là dell’adozione di modelli, tuttavia, il rischio di un’etichettamento degli interventi di mediazione nel nostro paese deriva dall’obbligatorietà e irrinunciabilità dell’azione penale, per cui essendo la committenza un’istituzione anche di controllo si rischierebbe di inficiare un setting protetto di negoziazione e ricomposizione del conflitto, vanificando così l’azione messa in atto dal mediatore, anche se con le migliori intenzioni.
Tanto doverosamente premesso, al fine di meglio comprendere la dinamica della struttura ad oggi adottata in Italia, quale Mediazione Penale Minorile, è possibile individuare, da un lato, l’apporto positivo di tale strumento, dall’altro, ovviamente, ancora le diverse criticità, che, nel tempo, andranno colmate, per rendere la mediazione penale uno strumento ancor più alternativo al processo penale minorile.
Sotto il primo profilo (apporto positivo), si possono individuare i seguenti aspetti.
Innanzitutto, finalmente la vittima del reato può acquisire un ruolo attivo nella vicenda che ha subito, ben potendo dar voce e visibilità della propria identità personale, sofferenza, rappresentare il proprio vissuto personale.
Si tratta di un approccio, in parte, introitato nel nostro sistema dall’area anglosassone, dove il risalto del ruolo della vittima ha assunto una posizione centrale nella Mediazione Penale Minorile attraverso il sistema c.d. VOM (da un lato Victim Offernder Mediation).
In secondo luogo, la Mediazione Penale Minorile offre all’autore del reato la possibilità di rieducazione, a condizione che riconosca l’errore e la consumazione del reato, senza, tuttavia, subire per sempre il fenomeno del c.d. “Etichettamento”.
All’autore del reato è consentito mediante questa alternativa al giudizio di prendere atto di una responsabilizzazione sul danno causato e sulla possibilità di riparare l’errore.
Si tratta di una forma empirica, che consente al Mediatore prima e, successivamente, al Magistrato, di valutare l’effettiva presa di coscienza da parte del minorenne, attraverso l’analisi comportamentale valutati mediante strumenti di comunicazione, ascolto, criminologici, etc., che possono portare ad una ragionevole certezza in merito all’effettiva volontà dell’autore del reato di voler riparare il danno nei confronti della vittima, anche del contesto sociale di riferimento.
Ancora, gli strumenti riparativi non hanno carattere “di condanna”, ma possono essere indicati quali opportunità di riparazione attraverso la riflessione, l’incontro (dapprima con i due Mediatori, a seguire, eventualmente, con la vittima), l’impegno responsabile di elaborazione del conflitto causato, il tutto garantito dalla riservatezza della procedura, che consente all’autore del reato di esprimersi con maggiore serenità e trasparenza rispetto ad un certamente più difficile area giudiziaria.
Sotto altro profilo, la Mediazione de qua favorisce la riapertura di canali comunicativi tra soggetti (autore del reato, Mediatori, eventualmente la vittima), attraverso strumenti diversi da quelli applicabili in sede giudiziaria: comunicazione non solo verbale, ma linguaggio del corpo, sviluppo delle emozioni (sensibilità personali, rabbia, frustrazione, pentimento, tristezza, etc.): emozioni sia dell’autore del reato, ma anche della vittima, la quale non ha alcuni luoghi, in sede giudiziaria o para-giudiziaria, ove poter manifestare liberamente le proprie difficoltà emotive, anche davanti all’autore del reato.
Sotto altro profilo, la “recente” (più che introduzione) concreta applicazione della Mediazione Penale Minorile, ha lasciato ancora aperti diversi punti di criticità, che tuttavia, si auspica, in tempi relativamente brevi, possano trovare soluzione, anche mediante l’osservazione di esempi stranieri della Mediazione Penale Minorile, laddove alcune di tali lacune sono già state superate.
La prima grande e criticata laguna attiene alla circostanza che, di fatto, la Mediazione Penale Minorile è oggi regolata a livello empirico e non normativo, motivo che crea, apparentemente, meno certezze a livello sociale.
Inoltre, la logica sociale è ancora portata a ritenere che colui che abbia “sbagliato” debba subire una reprimenda retributiva, e non esistano strumenti diversi, che, invece, hanno il ben diverso obiettivo di rieducare, affinché il soggetto non reiteri la violazione di legge.
Si tratta di una visione penalistica più a lungo termine, ma meno compresa a livello sociale.
Il terzo aspetto attiene alla “informalità” della procedura, rispetto a quella che costituisce l’insieme delle fasi processuali.
Anche tale aspetto crea ancora, nell’ottica comune, l’idea di una via “facile” di uscita dalla violazione penale.
A causa dell’informalismo e del consensualismo della procedura e, al contempo, per l’assenza di regole sia sostanziali che procedurali, la Mediazione potrebbe amplificare lo squilibrio dei poteri e aprire la porta alla coercizione e alla manipolazione da parte del più forte nel conflitto, al tempo stesso, la posizione di neutralità solleverebbe il Mediatore dal prevenire tutto ciò. Rispetto alle procedure formali-legali, la Mediazione avrebbe prodotto risultati ingiusti in quanto sproporzionatamente e ingiustificatamente favorevoli alle parti più forti.
In realtà, la complessa formazione professionale del Mediatore Penale Minorile (che, come detto, ha una formazione a 360 gradi, sia sotto il profilo tecnico – conoscenza del diritto penale, procedura penale, criminologia – sia sotto il profilo comunicativo – tecniche di comunicazioni non sono verbali, esperienza, tirocini, presenza sempre di due Mediatori, per consentire un equilibrio di gestione della procedura) superano già tale criticità, ma questo non è così ben percepito, a diversi livelli.
Altro aspetto critico attiene alla doglianza per cui vi sarebbe poca chiarezza su quale possa essere il modo migliore di organizzare le strutture di gestione informale dei conflitti; in particolare, su quali tipi di provvedimenti queste possano adottare e su quali casi possano intervenire; su quale sia il tipo di preparazione richiesta per farne parte e in generale, sulle procedure ad utilizzare e sulla legittimità rispetto all’ordinamento delle soluzioni adottate.
Vero che l’ammissione alla Mediazione Penale Minorile passa al vaglio della Magistratura, ma ancora preoccupa che il giudizio “finale” dei Mediatori (per quanto trattasi di un Collegio, rappresentato almeno da due soggetti, con competenze che si completano) possa essere ancora troppo soggettivo.
Inoltre, date la sua riservatezza e informalità, essa darebbe ai Mediatori ampi poteri strategici sul controllo della discussione, aprendo la strada all’affermarsi dei loro pregiudizi. Questi possono alterare la selezione e la forma dei problemi, il modo di strutturare e di valutare le opzioni, e molti altri elementi che influenzano la soluzione. Di conseguenza la Mediazione avrebbe spesso prodotto dei risultati ingiusti.
Altra criticità atterebbe alla vittima: se, da un lato, si è detto, che proprio la Mediazione Penale Minorile restituisce, in qualche modo, un ruolo a quest’ultima nel processo penale minorile, alcuni autori confutano detta tesi, facendo leva sul senso delle sanzioni.
Appellarsi alla Riparazione dal punto di vista della vittima è logico e rispecchia i suoi interessi, ma si esaurisce altrettanto logicamente in essi. L’orientamento alle vittime potenziali, invece, importa non la corrispondenza della riparazione ai bisogni della vittima, quanto orientare il senso della sanzione alla situazione della vittima potenziale.
Secondo alcuni autori, quindi, contrariamente a ciò che fa credere la retorica giustificativa della Mediazione Penale Minorile, allorquando questa associa l’esigenza di rivalutare e di ristabilire la soggettività della vittima nel processo penale, alla critica rivolta al diritto penale dello stato assistenziale e al suo essere orientato prevalentemente, vi sarebbe l’intenzione dello Stato di de-drammatizzare e razionalizzare il rapporto reo-vittima, sottraendo loro il diritto all’esercizio della violenza.